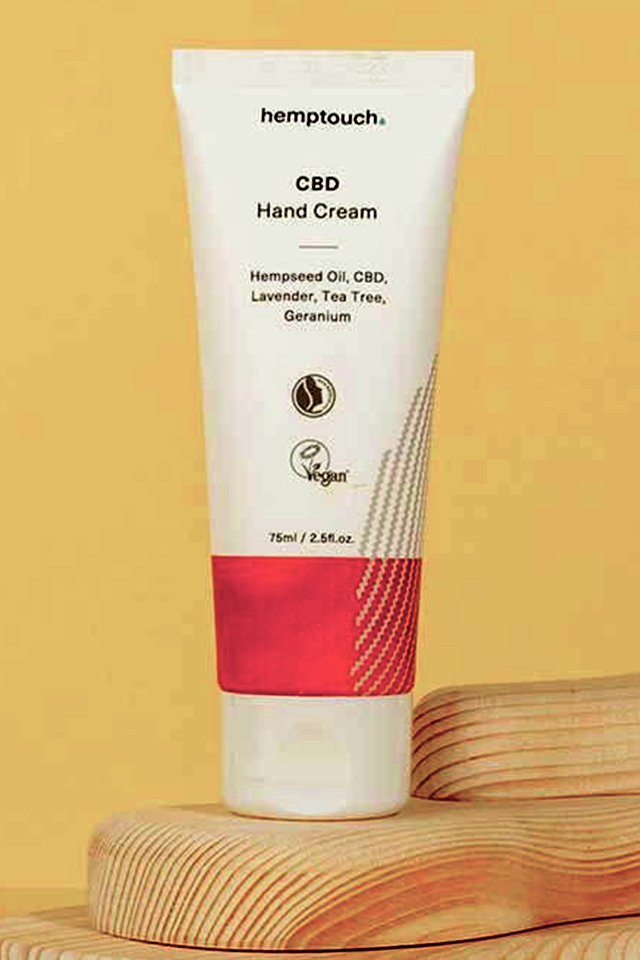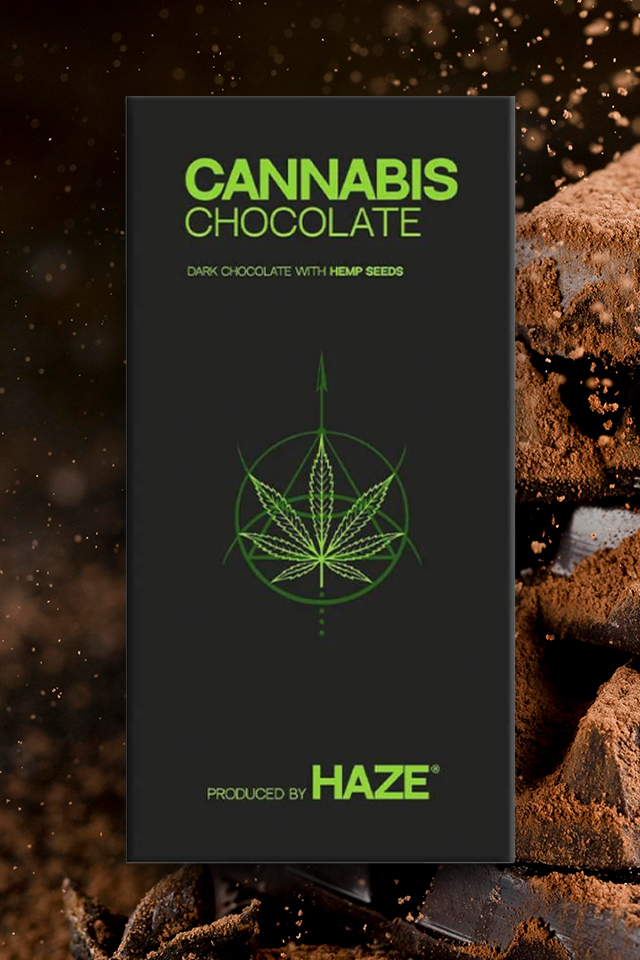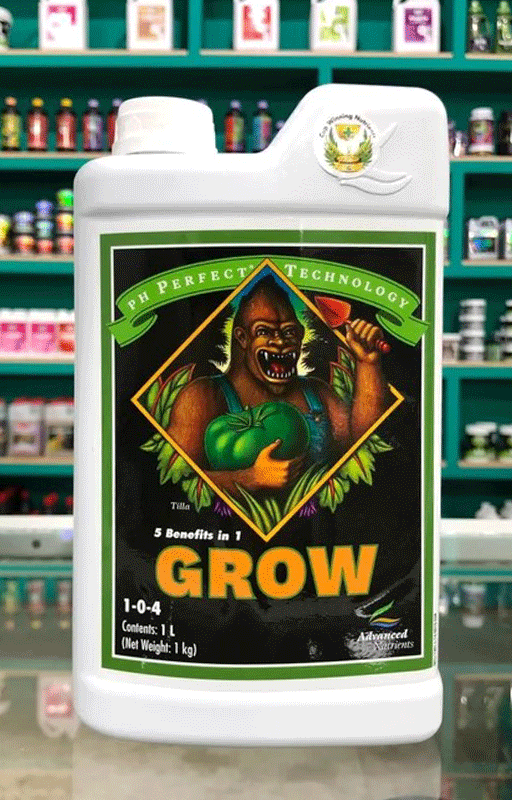La Cannabis in Italia
L’agricoltura della marijuana in Italia ha una lunga storia che ha inizio nell’epoca romana, quando la coltivazione avvieniva principalmente per la produzione di corde di canapa. Tuttavia, studi archeologici dimostrano che le piante di Cannabacee erano presenti in Italia sin dal tardo Pleistocene, anche se i primi segni del loro utilizzo risalgono all’età del bronzo. L’industria della canapa conosce un vero e proprio sviluppo durante le Repubbliche Marinare e l’Età della Vela, ed è rimasta attiva anche dopo l’Unificazione d’Italia. Tuttavia, ha subito una rapida decadenza nella seconda metà del XX secolo a causa dell’introduzione delle fibre sintetiche e della guerra alla droga. Negli ultimi tempi, però, ha cominciato lentamente a risorgere.
Oggi, in Italia, l’uso della cannabis è legale per scopi medici e industriali, sebbene sia strettamente regolamentato. Per quanto riguarda l’uso ricreativo, il possesso di quantità minime e l’uso personale della sostanza non è reato. È però un illecito amministrativo che può comportare sanzioni amministrative. Dalla semplice diffida fino a sanzioni più pesanti, il ritiro della patente o dei documenti per l’espatrio, che comunque non sono sanzioni penali. Al contrario, la vendita non autorizzata di prodotti derivati dalla cannabis è illegale e punita con sanzioni penali come la reclusione. Anche la coltivazione di cannabis senza licenza è un reato. Tuttavia, recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno stabilito la legalità della coltivazione di piccole quantità di cannabis esclusivamente per uso personale. La disciplina per il singolo consumatore è confusionaria e ha molte zone grigie.
La coltivazione autorizzata di cannabis per scopi medici e industriali è regolamentata. È richiesto l’uso di semi certificati, ma non è necessaria alcuna autorizzazione per la coltivazione di semi con livelli minimi di composti psicoattivi, conosciuti come “cannabis light“.
L’Antica Roma
Uno degli scrittori di punta dell’epoca della Repubblica Romana, il satirico Gaio Lucilio, fornì uno dei primi riferimenti alla canapa industriale nel II secolo a.C. Questa pianta divenne oggetto di menzione anche nella prestigiosa opera De re rustica di Marco Terenzio Varrone, scritta nel 37 a.C. È un trattato sull’agricoltura, in cui la canapa fece parte di un elenco di altre piante impiegate per le loro fibre, tra cui lino, giunco e palma. Nel I secolo d.C., Plinio il Vecchio descrisse la coltivazione e l’utilizzo della cannabis nella sua opera Naturalis Historia. Rivelò come questa pianta fosse impiegata sia per scopi industriali che medicinali nell’Impero Romano. La menzione della canapa non si limitò a queste opere, ma compare anche nelle satire di importanti poeti dell’epoca come Persio e Giovenale.
Nell’Antica Roma, si utilizzava la fibra di canapa principalmente per la produzione di corde robuste, lenzuola, vimini e reti. Il celebre storico Plinio, in particolare, menzionò tre varietà di canapa chiamate Alabandica, ritenute le migliori per la realizzazione delle reti da caccia. Quest’ultimo autore citò anche la varietà coltivata a Mylasa come una scelta di qualità inferiore. La canapa proveniente dalla regione Sabina, invece, si distingueva per la sua straordinaria altezza. Un’interessante scoperta archeologica avvenne a Pompei, in Campania. Durante gli scavi, gli archeologi riportarono alla luce frammenti di tessuti di canapa che erano miracolosamente rimasti intatti dopo l’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Tra questi reperti si contarono persino sandali realizzati in stoffa di canapa, sebbene nell’antichità il lino fosse generalmente preferito per la produzione di tele, vele e abbigliamento.
Purtroppo, non possediamo informazioni precise sull’estensione della coltivazione della canapa in Italia. Abbiamo alcune prove archeologiche non verificate e il riferimento di Plinio alla varietà di canapa coltivata nel territorio reatino, nella regione della Sabina. Tuttavia, due fonti epigrafiche di rilevante importanza dimostrano che i Romani coltivavano e commerciavano la canapa nella penisola italica. La prima consiste in un’iscrizione funeraria rinvenuta a Bovolenta, datata tra il II e il III secolo d.C. Questa fonte menziona il “cannabetum” come un’area riservata alla coltivazione della canapa. La seconda fonte è rappresentata da un’etichetta di piombo scoperta nella zona di Altino, risalente tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. Questa indicava un carico composto da sei gomitoli di lana e una quantità limitata di canapa. Questi rinvenimenti testimoniano le attività di coltivazione e commercio legate alla canapa svolte dai Romani nell’antica Italia.
-
La coltivazione della canapa
Nel corso dell’anno 2018, durante gli scavi effettuati lungo la riva est dell’antico fiume Natisone cum Torre di Aquileia, nell’area Venetia et Histria situata nell’attuale regione del Friuli-Venezia Giulia, gli archeologi trovarono reperti interessanti. Questi reperti hanno svelato l’esistenza del primo sistema di bacini di epoca romana utilizzato per la macerazione della canapa. Questa scoperta è emersa grazie a ricerche effettuate dagli archeobotanici e dagli archeopalinologi (che studiano i pollini, le spore e altri sporomorfi microscopici inglobati negli strati archeologici) sul sito in questione. Essi datarono i bacini rinvenuti sulla riva, caratterizzati da una forma lunga e poco profonda, tra la fine del secondo e il terzo secolo d.C. fino alla fine del terzo o agli inizi del quarto secolo d.C.
Le strutture erano delimitate da parapetti realizzati con argilla, sabbia e piccoli ciottoli e rivestite con sottili strati di cocciopesto per renderle impermeabili. Come si usa ancora oggi nelle più moderne tecniche di macerazione in acqua, si raggruppava i gambi di canapa in covoni e poi li si immergeva in acqua stagnante o corrente legandoli a speciali pali, con l’obiettivo di estrarne le fibre utili.
Studi condotti precedentemente in Veneto hanno dimostrato che la coltivazione della canapa nell’area dell’Alto Adriatico non era un’attività intensiva. Era piuttosto un’attività che garantiva l’autosufficienza di piccole comunità o, nel caso fosse svolta su scala più ampia, un’attività complementare all’industria laniera presente ad Aquileia. Inoltre, le acque termali ricche di zolfo, presenti nella zona intorno ad Aquileia, erano utilizzate per la macerazione sia della canapa che del lino. Successivamenti si impiegava questi materiali nella produzione di cordami e reti da pesca, nella fabbricazione di tessuti a base di lana mixata e nella lavorazione di lana e prodotti lanieri.
-
Il consumo della cannabis
Nell’Italia antica, diverse parti della pianta di canapa erano utilizzate per vari scopi culinari. Plinio, ad esempio, fa riferimento al fatto che i semi di canapa conservati in vasi per un utilizzo futuro, si mantenevano freschi per un anno intero, mentre i gambi e i rami venivano cucinati come verdure. Nel De re culinaria, una collezione di ricette della cucina romana che si pensa sia stata compilata nel V secolo d.C., è presente una ricetta per alimenti a base di cannabis destinati a banchetti nuziali, sebbene l’autore reale di quest’opera sia ancora incerto.
Riguardo alle credenze dell’epoca sulle piante di cannabis e sugli effetti del loro utilizzo personale, Plinio afferma che la canapa selvatica cresceva principalmente nei boschi. Era caratterizzata da foglie più scure e ruvide, e si diceva che i suoi semi causassero impotenza. Il succo della pianta era un ottimo rimedio per allontanare parassiti e altri organismi che entravano nelle orecchie. Come effetto collaterale, però, provocava mal di testa, ed era così denso che si diceva si coagulasse l’acqua una volta versato in essa. Inoltre, mescolando il succo di canapa con acqua, si otteneva una miscela in grado di regolarizzare il sistema digerente degli animali da soma.
Per quanto riguarda le proprietà mediche, si pensava che le radici di canapa bollite nell’acqua alleviassero i crampi alle articolazioni, la gotta e simili dolori violenti. Potevano anche essere applicate crude sulle ustioni, ma dovevano essere cambiate prima che si asciugassero. Il medico e botanico greco contemporaneo Discoride Pedanio, attestò la capacità delle radici di cannabis bollite di ridurre l’infiammazione nel suo De Materia Medica, una farmacopea che si concentra principalmente sulle piante medicinali.
Per quanto riguarda l’uso ricreativo della cannabis nell’Impero Romano, il medico e filosofo greco del II secolo Claudio Galeno scrisse che era consuetudine in Italia servire piccole torte a base di cannabis per dessert. I suoi semi avrebbero creato una sensazione di calore e, se consumati in grandi quantità, colpiscono la testa emettendo un vapore caldo e tossico.
Uno studio del 2019 ha cercato di riprodurre il modo di vivere di una comunità romana imperiale vissuta tra il I e il III secolo d.C. nei pressi di Cures Sabini. Durante l’analisi etnobotanica, sono stati trovati 11 frammenti di tessuto vegetale delle Cannabacee nei depositi dentali di 27 individui sepolti nella necropoli di Passo Corese.
Campioni di fibre di canapa sono stati identificati tramite microscopio ottico, confrontati con collezioni in laboratorio, dati di ricerca precedente e contesto culturale e cronologico.
Le possibili spiegazioni per la presenza di fibre di canapa nei depositi dentali includono:
- Inalazione durante la lavorazione della canapa
- Ingestione di cibi e bevande conservati in sacchi di canapa
- Uso terapeutico di essudati ed estratti di canapa.
Il Medioevo

Dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente nel 476 d.C. e il periodo migratorio tra il IV e il VI secolo d.C., le informazioni dettagliate sulla coltivazione della canapa in Italia prima del 1000 d.C. sono poche. Tuttavia, è comprovato che la lavorazione industriale e commerciale della canapa era diffusa in quel periodo. Nonostante ciò, sembra che la coltivazione della cannabis in tutta Italia fosse stata fortemente limitata. Soprattutto tra il IV e l’VIII secolo d.C., dato che gran parte delle campagne erano state lasciate in abbandono.
È nel Medioevo che la coltivazione su larga scala della cannabis industriale ha davvero iniziato a svilupparsi. Questo avvenne grazie alla ripresa demografica e agricola, alla nascita dell’industria tessile, dei Comuni medievali e delle Repubbliche Marinare, nonché all’incremento dei commerci nel Mediterraneo.
Una delle prime menzioni dell’utilizzo dell’hashish nella letteratura italiana si trova nel libro “Il Milione”. Qui il mercante ed esploratore veneziano Marco Polo racconta i suoi viaggi in Asia tra il 1271 e il 1295. Lo scrittore pisano Rusticiano è l’autore di questo resoconto. Egli era stato prigioniero insieme a Marco Polo durante la guerra di Curzola del 1295-1299.
Nel diario di viaggio, i due autori citano il Vecchio della Montagna, un riferimento al condottiero persiano Hasan-i Sabbah. Egli fu il fondatore dello stato di Nizari Ismaili nel 1090 dopo aver conquistato la fortezza montana di Alamut. L’Ordine degli Assassini, di cui Hasan-i Sabbah fu il primo Gran Maestro, deve il suo nome alla parola hashshāshīn, che significa utilizzatori di hashish. Sia la droga che il Vecchio sono successivamente menzionati nel Decamerone, una raccolta di racconti scritti dal poeta fiorentino Giovanni Boccaccio nel 1353.
-
L’uso industriale della Cannabis
Nel passato, la popolazione sfruttava le piante di canapa in tutto il loro potenziale. Si utilizzava le loro radici come legna per il fuoco, si immergeva i pezzi di fusto nello zolfo per creare fiammiferi. I semi erano destinati all’alimentazione del bestiame. La fibra era impiegata per la realizzazione di reti da pesca, corde per attività agricole e tessili, e per confezionare biancheria di pregio, sacchi per la farina, abiti e corredi per le nozze. La resistenza delle fibre di canapa le rendeva adatte anche per essere mescolate con la lana pregiata e creare tessuti resistenti all’usura. Allo stesso modo, la combinazione di fibre di canapa con lino o lana, chiamata “pignolato”, era molto diffusa nel ferrarese per la produzione di abiti.
Ancora oggi, nel territorio di Sant’Arcangelo di Romagna si utilizza la canapa per creare tessuti come coperte, federe e tovaglie. La creazione di questi tessuti avviene tramite un processo artigianale tramandato dall’antichità che prevede la levigatura e l’ammorbidimento del tessuto grezzo. La canapa ha anche avuto un ruolo significativo nella produzione di carta, diffondendosi dalla Cina all’intero mondo musulmano. Arrivè poi in Italia nel XIII secolo, con la fondazione della prima cartiera nel 1276 a Fabriano. Qui gli artigiani locali perfezionarono le tecniche arabe di produzione della carta, utilizzando principalmente canapa e lino. Grazie al terreno ricco di calcio in molte parti d’Italia, le piante di cannabis sativa producevano fibre di colore chiaro, che conferivano alla carta una tonalità bianco crema molto apprezzata. Inoltre, le fibre lunghe garantivano alla carta resistenza e flessibilità, rendendola un materiale ottimale per libri e manoscritti, sempre più scelto rispetto alla costosa pergamena.
-
L’uso internazionale della canapa italiana
La canapa italiana godeva di grande reputazione già prima dell’unificazione del Paese nel 1861. Infatti, fin dal suo ingresso nel mercato del Regno Unito nel 1820, era riconosciuta per la sua eccellente qualità, resistenza e durata. Inizialmente era utilizzata prevalentemente per la produzione di reti da pesca, nonostante il suo costo più elevato rispetto agli altri materiali. Si narra che i contadini italiani seminassero la canapa nei loro migliori terreni, caratterizzati da un suolo ricco e solido, e si preoccupassero di rendere la superficie fine e friabile attraverso l’utilizzo di una miscela di letame, pezzi di stoffa, piume e corna importate dalla Dalmazia.
Tuttavia, la coltivazione della canapa è possibile in ogni tipo di terreno, ottenendo fibre di varia qualità. I Paesi con terreni più poveri, in particolare, produssero fibre più sottili, ma in quantità limitata. Al contrario, i Paesi con i terreni più ricchi di nutrienti generavano piante dalla fibra di maggior spessore, essenziale per la fabbricazione di cavi, corde ed altre attrezzature pesanti.
Il regno d’Italia

-
Uso medico della cannabis
Durante la fine dell’era moderna, si attribuisce comunemente ai soldati francesi il diffondersi dell’uso della cannabis a scopo ricreativo in Europa. La mancanza di alcol durante il periodo delle campagne spinse i soldati a sperimentare l’hashish come alternativa. Tuttavia, il primo studio scientifico sull’uso medico della cannabis lo effettuò, nel 1839, il dottore irlandese William Brooke O’Shaughnessy. Egli somministrò medicinali a base di cannabis ai suoi pazienti affetti da diverse malattie, come epilessia e reumatismi, notando gli effetti anticonvulsivanti, analgesici e antiemetici.
In Italia, nel 1887, il dottor Rffaele Valieri, primario dell’Ospedale degli Incurabili a Napoli, fece uno dei primi tentativi di curare i pazienti con la varietà di cannabis indica. L’ospedale si occupava della cura dei pazienti in condizioni di estrema povertà. In particolare aveva affrontato quattro gravi epidemie di colera che avevano colpito la città tra il 1855 e il 1884. A causa del sovraffollamento delle aree più povere e dalla mancanza di un adeguato sistema fognario, ci furono molti morti. Di conseguenza, nel 1885, si avviarono importanti progetti di riqualificazione. Il dottor Valieri dedicò anni alla sperimentazione dell’uso medico della cannabis per il trattamento di disturbi nervosi, sia sui pazienti che su sé stesso. Testò diverse modalità di somministrazione e prendendo appunti sia sugli effetti positivi che su quelli avversi.
Il dottor Valieri ha condotto sui pazienti dei test sui diversi metodi di somministrazione della cannabis terapeutica, come: masticarla, fumarla in pipe e sigarette, bevendone decotti, infusi e liquori oppure usandola sottoforma di acqua distillata, pillole, perle, oli essenziali, tinture ed estratti. Secondo le sue scoperte, la cannabis medica si è dimostrata efficace nel trattamento di molte malattie come:
- Isteria
- Asma
- Enfisema polmonare
- Emicrania
- Gozzo esoftalmico
- Ipercinesia facciale e altre nevrosi provenienti dal sistema nervoso centrale e periferico, inclusa:
- La nevralgia dei nervi trigemini
- Il plesso cervicale occipitale
- Il plesso brachiale
- Il plesso lombare
- Il plesso sacrale
Il dottor Valieri ha iniziato a fare pressioni sulle autorità sanitarie per rendere la cannabis più accessibile ai pazienti, riducendo il suo costo. Inoltre, ha lottato per l’istituzione di sale per l’inalazione nelle ASL, simili a quella che ha creato nel suo ospedale. Qui i pazienti avrebbero potuto inalare il fumo terapeutico prodotto dalla combustione della cannabis.
La principale difficoltà riscontrata nella diffusione della cannabis terapeutica in Italia fu l’assenza sul mercato italiano della popolare varietà indiana, a differenza di altre parti del mondo dove il suo utilizzo clinico era consolidato già alla fine del XIX secolo. Per superare questo problema, il Dr. Valieri ha studiato le proprietà medicinali di alcune varietà italiane trovate a Casoria, scoprendo che, sebbene gli effetti fossero simili a quelli sperimentati con la cannabis indica, era necessario raddoppiare la dose prescritta in precedenza.
Tuttavia, durante il XX secolo, l’uso medico della cannabis ha subito una significativa diminuzione a livello globale. Le cause furono ad esempio l’introduzione di trattamenti più efficaci per diverse malattie, l’instabilità farmacologica della cannabis derivante dal fatto che il suo principio attivo (THC) non era ancora isolato, e di conseguenza gli effetti risultavano imprevedibili e difficili da standardizzare. Inoltre, vi erano i costi economici associati all’importazione del medicinale dall’estero, soprattutto considerando il contesto di due Guerre Mondiali.
-
Prime proibizioni della cannabis
Durante le prime fasi della proibizione internazionale della cannabis, gli Stati Uniti non hanno svolto un ruolo di leadership, mentre il contributo di Italia, Sudafrica, Egitto e Turchia è stato in gran parte trascurato. Durante la Prima Conferenza Internazionale sull’oppio tenutasi all’Aia nel 1911-1912, l’Italia ha spinto per ottenere un divieto internazionale della cannabis. Principalmente a causa dell’ampia diffusione dell’utilizzo di hashish nelle sue colonie nordafricane della Tripolitania e della Cirenaica. Quest’ultime erano state annesse dall’Impero Ottomano dopo la guerra italo-turca del 1911-1912. Visto però che la conferenza del 1912 era incentrata sull’oppio, sebbene sia stata affrontata la questione della canapa indiana, non sono state adottate misure significative in tal senso. Invece, la regolamentazione sulla cannabis è stata introdotta durante la Seconda Conferenza Internazionale sull’Oppio, svoltasi a Ginevra nel 1925, grazie all’influenza dell’Egitto e alle precedenti pressioni provenienti dal Sud Africa e dall’Italia, tra gli altri.
L’accordo raggiunto nella Convenzione sull’oppio del 1925 riguardante la cannabis era un compromesso che stabiliva restrizioni esclusivamente per scopi medici e scientifici nella produzione, importazione, vendita, distribuzione, esportazione e uso di estratti e tinture di canapa indiana. Questo compromesso non rappresentava un divieto totale. Si limitava, infatti, solo al commercio internazionale della cannabis e non vietava la sua produzione, né imponeva controlli sul traffico o sul consumo interno, e non richiedeva stime di produzione governative.
Il testo finale ha apportato modifiche al linguaggio utilizzato nella bozza iniziale proposta. Ciò ha causato obiezioni da parte di paesi come l’India, dove le preparazioni più leggere a base di cannabis erano spesso utilizzate in eventi sociali, cerimonie religiose e festival. Anche se l’uso di hashish più potente era generalmente disapprovato. Per quanto riguarda questa questione, il Regno Unito è rimasto ambivalente, mentre gli Stati Uniti si sono concentrati principalmente sull’oppio.
Negli anni ’30, Mussolini enfatizza l’importanza della canapa in termini di economia agricola e sociale. Tra il 1936 e il 1940 la produzione di canapa in Italia raggiunge un record storico di oltre centomila tonnellate. Tuttavia, il destino del settore è segnato: seguendo il divieto affermatosi negli Stati Uniti nel 1937, quando la cannabis diventa illegale in tutto il paese attraverso il Marihuana Tax Act, anche Mussolini decide di sostenere politiche proibizioniste. Prima dell’avvicinamento alla Germania nazista, infatti, il governo italiano e quello statunitense hanno buoni rapporti e Mussolini negli anni ’30 definisce la cannabis una “droga da ne*ri”, anche se praticamente nessun italiano ne fa uso.
L’introduzione della cannabis nell’elenco delle sostanze stupefacenti nel Codice Penale del 1930 comporta la previsione di pene severe per la vendita e l’agevolazione del consumo di sostanze proibite. Anche per chiunque sia colto in stato di grave alterazione mentale a causa dell’abuso di stupefacenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o in circoli privati. Non sono previste sanzioni penali per il consumatore, ma il consumo viene considerato una patologia da trattare obbligatoriamente presso centri specializzati per la salute mentale.
La Repubblica Italiana
Negli anni ’50 e ’60, durante il periodo di boom economico, l’Italia ha subito un declino nella produzione di canapa a causa dell’introduzione di fibre sintetiche come il nylon sul mercato e dell’aumento della lotta internazionale contro gli stupefacenti. In quel periodo, la coltivazione della cannabis industriale è quasi completamente scomparsa dalla maggior parte dei paesi dell’Europa occidentale. Ad eccezione di Francia e Spagna che hanno continuato a coltivarla, seppur con tendenze diverse. Questo calo significativo è principalmente attribuito alla concorrenza dei tessuti industriali e del cotone nell’industria tessile, dei materiali metallici per le corde navali, e del manila e della juta per gli imballaggi durante i viaggi marittimi a lungo raggio.
Altri fattori che hanno contribuito a questa situazione includono:
- Introduzione di regole più rigide per la coltivazione della canapa tessile.
- Aumento dei costi del lavoro che non potevano essere facilmente sostituiti con la meccanizzazione.
- Impatto ambientale delle vasche di macerazione.
Inoltre, l’Italia ha aderito a tutti e tre i principali trattati sul controllo degli stupefacenti, come la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, la Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 e la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988. Appena dopo l’approvazione della legge antidroga Cossiga 685/75 nel 1975, i campi di canapa in Italia sono praticamente spariti.
-
Il proibizionismo
La Legge 685/75 ha introdotto il concetto di modesta quantità al fine di distinguere tra coloro che si limitano a consumare stupefacenti e coloro che li spacciano, con l’intenzione di punire i secondi. Prima di questa legge, tale distinzione non era prevista. Tuttavia, la mancanza di una definizione specifica di ciò che costituisce una modesta quantità di una certa droga ha lasciato la materia alla discrezionalità dei giudici. Di conseguenza, la Suprema Corte di Cassazione ha emesso delle linee guida al fine di garantire la coerenza delle decisioni giudiziarie. In particolare, queste linee guida stabilivano che una quantità modesta non si riferiva necessariamente a una quantità specifica di stupefacenti. Inoltre, prima di pronunciare un verdetto, un tribunale doveva valutare il livello di tossicodipendenza dell’imputato. Inoltre, doveva determinare scientificamente la natura e la composizione degli stupefacenti sequestrati, nonché la quantità media di principi attivi ottenibili da essi.
Tuttavia, la cosiddetta Legge Iervolino-Vassalli, contenuta nel DPR 309/90 del 1990, ha sostituito il concetto di quantità modesta con quello di dose media giornaliera. Con questa legge, sono state stabilite le quantità massime di farmaci legalmente consumabili per ognuno di essi, attraverso un Decreto Ministeriale. All’interno del decreto del Presidente della Repubblica 309/90, un individuo affetto da tossicodipendenza è da considerare come un paziente che ha bisogno di riabilitazione e, quindi, non soggetto al sistema penale. Può però comunque essere punito con sanzioni amministrative.
Queste sanzioni includono la sospensione della patente di guida, del porto d’armi e del passaporto, per un periodo minimo di un mese e massimo di un anno. Tuttavia, nel 1993, il Partito radicale, sotto la guida di Marco Pannella, è riuscito a far abrogare con un referendum le sanzioni penali per l’uso personale di droghe leggere. In conseguenza, il concetto di dose giornaliera media è stato eliminato e la discrezionalità giudiziaria caso per caso è stata reintrodotta.
Nel 2006, la controversa legge Fini-Giovanardi 49/06 ha eliminato la distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, rendendo quindi punibile il possesso di marijuana e hashish in modo simile alla detenzione di eroina o cocaina. Questa situazione è durata fino a quando la Corte costituzionale ha dichiarato la legge incostituzionale nel 2014. La decisione di considerare incostituzionale la legge 49/06 non si basava sul suo contenuto, ma piuttosto sul modo in cui il disegno di legge iniziale è stato convertito in legge, essendo stato allegato a un provvedimento che riguardava diverse questioni.
In ogni caso, la Legge 49/06 ha portato ad un aumento significativo delle pene detentive per vendita, coltivazione e detenzione di cannabis. Le condanne sono passate da 2-6 anni a 6-20 anni, causando un sovraffollamento delle carceri italiane. Il 40% dei detenuti sono stati imprigionati per reati correlati alla droga, nonostante il fatto che il consumo di cannabis non sia mai stato criminalizzato. Inoltre, la legge ha introdotto il criterio di quantificazione della quantità di principio attivo presente nelle droghe sequestrate, nonché una politica di tolleranza zero verso comportamenti e circostanze che potrebbero indicare traffico di stupefacenti. Di conseguenza, si commette reato se la quantità di principio attivo supera i limiti stabiliti dalla Tabella Ministeriale. Per la cannabis è fissata a 500 mg, corrispondenti a un peso lordo di circa 5 g, ovvero circa 15-20 spinelli.
Dal 2014, il Decreto-legge Lorenzin 36/14 rappresenta la normativa principale riguardante gli stupefacenti. Questo decreto ha introdotto cinque Tabelle delle Sostanze, che vengono pubblicate dal Ministero della Salute. Le varie sostanze controllate sono suddivise nelle diverse tabelle in base al grado di pericolosità accertata. La cannabis attualmente rientra nella seconda tabella, insieme ai suoi derivati. Di conseguenza, sono ancora esistenti sanzioni legali riguardanti il commercio e il consumo di cannabis, sebbene siano meno severe rispetto al passato. Nello specifico, il possesso di cannabis per uso personale è ora depenalizzato e punito con multe e il sequestro di documenti personali, come passaporti e patenti di guida. Tuttavia, la coltivazione e la vendita di cannabis senza licenza rimangono ancora illegali. Possono portare a una reclusione da 2 a 6 anni, oltre a una sanzione pecuniaria che va da 26.000 a 260.000 euro.
Da menzionare, inoltre, la sentenza numero 40 del 2019 della Corte costituzionale. Questa ha stabilito l’illegittimità della “pena minima della reclusione di otto anni anziché sei” prevista per coloro che si occupano di traffico di droga, come la coltivazione, produzione, vendita, distribuzione e trasporto di sostanze stupefacenti.
Nonostante ciò, il sovraffollamento delle carceri continua a essere un problema. Secondo l’ultima edizione del Libro Bianco, un rapporto annuale che valuta gli effetti delle politiche di proibizione in Italia, si afferma che “senza i detenuti per l’articolo 73 (del dpr 309/90) non ci sarebbe sovraffollamento nelle carceri”. Inoltre, per quanto riguarda le segnalazioni per semplice consumo, per il quale sono invece previste sanzioni amministrative, “dal 1990 sono state segnalate 1.312.180 persone, di cui il 73,28% per consumi di cannabis e suoi derivati”.
Nel 2016, la legge 242/16 sulla cannabis light ha eliminato l’obbligo di ottenere un’autorizzazione per coltivare semi di cannabis con livelli di THC inferiori allo 0,2%, che è più basso del limite dello 0,3% stabilito dal Regolamento UE 2021/2115 del 2 dicembre 2021. Tuttavia, durante le ispezioni in campo, viene considerato ancora accettabile un livello di THC compreso tra lo 0,2% e lo 0,6%, a condizione che sia attribuibile a cause naturali. La legge impone inoltre agli agricoltori di conservare le ricevute di certificazione per un anno. Inoltre, vieta loro di piantare semi di canapa provenienti da raccolti precedenti, nonché di utilizzare le foglie e le infiorescenze di cannabis per prodotti commestibili. Il Corpo Forestale dello Stato ha il compito di controllare il rispetto delle norme legali da parte degli agricoltori. Altri enti governativi possono effettuare ispezioni se necessario.